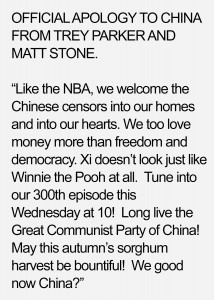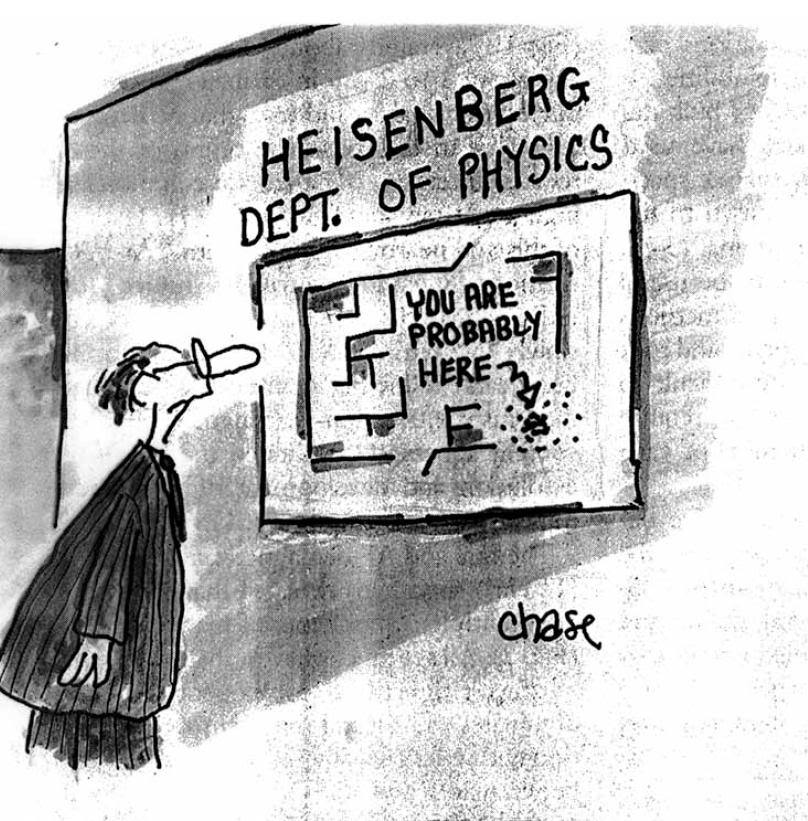Sono stato in gita a palazzo Chigi
( pubblicato su 7 – Corriere della sera, il 23 febbraio 2018)
La prima cosa che ti dicono all’ingresso visitatori di Palazzo Chigi è «spegnere il cellulare»; la prima cosa che fanno tutti appena superato il metal detector è fotografare il cortile con il cellulare. Di stranieri, nel gruppo di visitatori di cui faccio parte, non ne vedo, il che è un po’ un peccato perché sarebbe stata per loro una rapida lezione di italianità. Durante la mia visita turistica a Palazzo Chigi di cose da immortalare e rivendere a stati canaglia, Isis e Spectre varie non ne incontrerò comunque nessuna. Il punto delle foto compulsive – nel gruppo c’è pure un signore con una reflex che appena rimane solo spara rapide sequenze furtive, come se nessuno si accorgesse dell’accrocchio di due chili che ha a tracolla – è un altro. Il cortile, come molti altri ambienti che s’incontrano durante la visita, è uno dei luoghi “della televisione”, di quelli cioè che si vedono durante il telegiornale e sono quindi oggetto del meccanismo di riconoscimento, sollecitato dalla guida, da parte del pubblico di visitatori. Il tour di Palazzo Chigi si può fare due sabati al mese da ottobre a marzo, previa prenotazione, con largo anticipo per i grandi gruppi, anche due giorni prima se siete da soli (l’unico da solo peraltro sono io).
CHE TIPO DI PERSONA, VI STARETE CHIEDENDO a questo punto, mentre è in gita a Roma, città dal patrimonio artistico che tende a infinito, decide di dedicare un’ora alla visita di Palazzo Chigi? Nel caso del mio gruppo l’età è alta (diciamo dai cinquanta in su), gli accenti quasi tutti del nord con una netta predominanza di veneti – un po’ a sorpresa un po’ no, perché spesso ci attira proprio ciò che odiamo, temiamo e mette aliquote sul reddito che raggiungono il 43%. Da alcune giacche spuntano quotidiani di destra e c’è un manipolo, molto ridotto, di specializzati in “palazzi del potere” che si sono già sparati Camera, Senato e Quirinale. Fra di loro anche uno dei pochi giovani dell’intera compagine, un ragazzo segaligno che sembra sapere tutto e si guarda attorno come si trovasse in un luna park. Il tempo, confido, lo renderà ironico e disilluso quanto gli altri. O presidente del Consiglio. Per il resto si tratta appunto di vedere luoghi che in forma catodica abbiamo già visto migliaia di volte, entrare sul set del nostro House of Cards. La guida è una giovane donna che si trascina dietro il figlioletto alle prese con «un attacco di mammite, è la prima volta che succede una cosa del genere», garantisce mentre chiede scusa.
IL PUBBLICO SI DIVIDE FRA indifferenti e una quota di nonne che si producono in «uuuhhh» «ihhhhh» e «che carino», antico riflesso pavloviano che si scatena in presenza di pupo italico indisciplinato, cosa che senza dubbio nel tempo ci renderà competitivi nei confronti dei cinesi. Nonostante abbia una creatura appesa a una gamba, la guida snocciola storie, nomi e dati come una che sa il fatto suo: volendo si può classificare questa capacità come lezione di italianità n.2. Si parte dagli Aldobrandini che costruiscono il palazzo abbattendo un gruppo di edifici preesistenti, si passa per i Chigi che lo rialzano in una di quelle gare di altezza degli immobili che contraddistinguono le civiltà che ancora non hanno scollinato verso la fase decadente, e di passaggio in passaggio si arriva all’attuale destinazione d’uso, piuttosto recente, visto che è datata 1961. Bisogna anche tenere presente, e il manipolo di feticisti dei “palazzi del potere” annuisce compatto quando la nostra madre-guida lo ricorda, che di tutte le sedi istituzionali Chigi è la più spoglia – i precedenti proprietari si sono portati via quasi tutto prima di venderlo allo Stato – e forse è pure la più brutta, ma questo, specifico, lo aggiungo io.

LA DELUSIONE MAGGIORE COMUNQUE per noi turisti del già visto è la sala stampa, quella dove vengono riprese le conferenze dopo le riunioni del Consiglio dei ministri. È piccolissima e il soffitto fa un effetto cartongesso non proprio di grande classe. La cosa non sfugge a nessuno, tanto che partono le tesi su quale complessa teoria d’illusioni ottiche debba essere stata necessaria per dotare di autorevolezza i filmati che da questo luogo giungono nelle nostre case: «Sono gli specchi» avanza qualcuno. «Anche le luci», aggiunge la guida che comunque chiosa «è la sala più tecnologica del palazzo» il che, concretamente, significa che ci sono quattro telecamere. Va infatti tenuto presente che Chigi, almeno nella parte che ci mostrano, non è proprio la sede di Google, la cosa più avanzata tecnologicamente essendo le berline di rappresentanza parcheggiate nel cortile. Sulle postazioni dei ministri nella sala del Consiglio ad esempio fanno capolino vecchi computer portatili color violetta e i microfoni hanno tutta l’aria di aver vissuto le notti magiche di Italia 90. Se poi siete di quelli che credono al simbolismo sappiate che la “sala delle scienze” qui è un’anticamera con un tavolo e una stampante. Particolari di un potere in netta dissonanza con il suo tempo che però naturalmente non turbano nessuno, al contrario vibriamo tutti all’unisono in virtù del medesimo, ovvio, retropensiero quando ci viene mostrato lo stemma dei Chigi «molto simile al logo di una moderna istituzione bancaria». Si tratta in effetti di una piccola piramide di colli che ha giusto una fila in più rispetto allo stemma del Monte dei Paschi di Siena, città che ha dato i natali alla famiglia dei Chigi, il che spiega la somiglianza.
E COSÌ MENTRE C’È CHI PENSA che in fondo era destino, ci illustrano il solenne cerimoniale di fronte allo scalone d’onore, per l’occasione percorso a pancia in giù dal bambino di cui sopra. A questo punto il bambino viene rimosso da un uomo e tutti chi chiediamo «ma sarà un parente?» e quando la guida continua per nulla turbata dal ratto del puero concludiamo che sì, sarà senza dubbio un parente. Non riusciamo a vedere il salottino giallo perché dentro c’è il presidente del Consiglio (chi è che è adesso? Gentiloni, ah già), ma in compenso vediamo diverse altre sale, compresa appunto quella del Consiglio dei ministri dove a parte la tavola rotonda e le sedie ci sono tre cose tre: una copia della Costituzione, un busto di De Gasperi («guarda che naso tipicamente romano» Alcide De Gasperi, luogo di nascita: Pieve Tesino, Trento), e una bacheca dove per qualche motivo non è custodito, chessò, l’elenco dei Nobel italiani, ma le medaglie delle Olimpiadi che si sono svolte nel nostro Paese prima dell’avvento di Virginia Raggi.
La vera hit comunque si rivela la sala dove sono appese alle pareti le foto di tutti i presidenti del Consiglio dall’Unità ad oggi. «Guarda che giovane il Berlusca, guarda lì il Mortadella». Sotto la foto sono indicati tutti i singoli mandati di ogni presidente, e partono quindi immediatamente le classifiche complessive per vedere chi ha le statistiche migliori da quando è stato fondato il campionato. C’è anche qualcuno a cui piace vincere facile e, scrutando le date, osserva ammirato «Mussolini più di vent’anni eh». La cosa più interessante sono però forse le espressioni, le posture e l’abbigliamento degli ultimi politici che hanno ricoperto l’incarico: c’è Romano Prodi impegnato ad esprimere bonarietà tranquilla e rassicurante (ovvero a impersonare Romano Prodi), Silvio Berlusconi giovanissimo, Enrico Letta (ah già, Letta!) senza giacca, Massimo D’Alema che prova lo sguardo verso l’infinito in una parodia di Che Guevara, Mario Monti con un sorrisino rassegnato che sembra intuire cosa diranno di lui un giorno i visitatori e infine c’è un Matteo Renzi che guarda in alto a sinistra come se ad una finestra del palazzo alle spalle del fotografo stesse succedendo qualcosa di parecchio grave e inaspettato, la bocca socchiusa nel broncio di chi è un po’ sorpreso e assieme deluso da quello che vede. «Nel caso ve lo steste chiedendo, le foto vengono scelte dai diretti interessati». In effetti, me lo stavo giusto chiedendo.