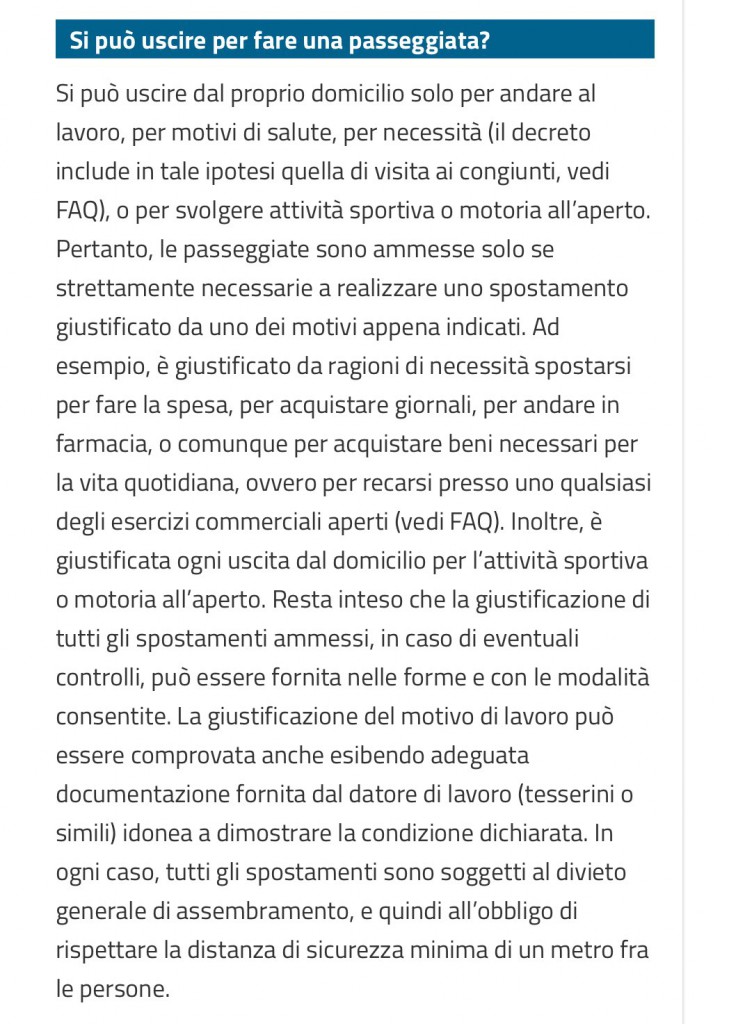L’età del tribalismo (intervista a Minima & Moralia)
Di Nicola Pedrazzi
Intervista apparsa su Minima & Moralia il 24/07/2020
Conosco Daniele Rielli dal 2013, gli scrissi la prima mail all’indomani della non-vittoria di Pierluigi Bersani alle elezioni politiche. Al tempo scriveva sotto pseudonimo e stava guadagnando una buona visibilità con il suo blog, un contenitore di soggettive molto ben costruite, che credo abbia unito nella lettura tanti quasi trentenni italiani. Da quella mail si è sviluppata un’amicizia per lo più epistolare, con due o tre momenti fisici di livello, come quando l’ho ospitato a casa mia a Tirana durante il reportage sull’Albania, la cui versione estesa è confluita in Storie dal Mondo Nuovo (Adelphi, 2016). Pochi mesi prima di raggiungermi sull’altra sponda dell’Adriatico, Daniele aveva pubblicato il suo primo romanzo, Lascia stare la Gallina, di cui Odio, appena uscito per Mondadori, eredita il protagonista. Insomma un po’ per caso e un po’ per volontà, mi è capitato di seguire da vicino il lavoro e la crescita di uno scrittore italiano contemporaneo: dal successo online alla riflessione sulle tribù digitali.
Quella che segue è la risistemazione di una chiacchierata attorno a Odio, un romanzo che è un viaggio nell’innominato tecnologico del nostro tempo, un’analisi filosofica delle meccaniche profonde dell’essere umano e non da ultimo una spumeggiante commedia italiana: goduriosa da leggere, e «basta». Non avrà il distacco professionale che da lettore pretendo dalle interviste, ma, con il consenso di Daniele, ho pensato avesse senso condividerla con qualcuno diverso da Google, veicolo e proprietario dei nostri carteggi pluriennali. Anche questo fatto, come vedremo, ha a che fare con il romanzo.
Il protagonista di Odio è Marco De Sanctis, che in gioventù (in Lascia stare la Gallina) è stato ingiustamente accusato di omicidio e non ha mai dimenticato il linciaggio mediatico cui è stato sottoposto. Marco costruisce Before, un’azienda di profilazione i cui algoritmi sono in grado di generare previsioni utili a qualsiasi attività commerciale. In sintesi, un ragazzo che ha provato sulla sua pelle la meccanica dell’odio in rete scala la tecnologia fino alla stanza dei bottoni, impara cioè a «trattare» le emozioni condivise e a estrarne profitto. Il matrimonio tra Marco e la tecnologia in qualche modo gemma dal suo disprezzo, che nei momenti buoni è semplice consapevolezza, nei confronti di cosa sta diventando il mondo, dalla sua sete di rivalsa se non di vera e propria vendetta. Al netto degli epiloghi, in Marco c’è un po’ di Edmond Dantes, il suo appartenere al futuro non gli impedisce di essere «classico»…
Prima di arrivare alla tecnologia Desa passa rapidamente per il mondo della politica – seppur in una posizione periferica – e rispetto a questo c’è un atteggiamento ambivalente del personaggio: da un lato l’occasione che gli capita è troppo grossa per ignorarla e con questo intendo non solo il potenziale di ricchezza economica e materiale ma anche, e nel suo caso forse soprattutto, la possibilità di accesso a situazioni, contesti, realtà che gli sarebbero altrimenti precluse e che gli sono sempre interessate molto. Vedere da vicino il mondo del potere e quello dei media non è una cosa che capita tutti i giorni a un giovane uomo di provincia. Accettare di confrontarsi con il mondo significa però intraprendere anche un percorso conoscitivo che mette in discussione le proprie certezze, significa anche superare confini intellettuali piuttosto angusti dove è sempre molto chiaro chi ha ragione e chi torto, dov’è il giusto e dove lo sbagliato, senza eccezioni di sorta. Per inciso un ambiente del genere è anche l’ideale per la crescita del risentimento. L’ambivalenza è anche data dal fatto che questo percorso è parallelo al rompere quella specie di quarta parete spersonalizzante che è lo schermo del computer e all’entrare davvero nel mondo degli uomini, che è un mondo fatto di sfumature e mal sopporta quegli assoluti che invece sono perfetti per ottenere risultati dentro l’architettura delle piattaforme digitali.
Significa prendere su di se l’onere del vivere in un mondo dove non è sempre così chiaro e immutabile chi sia la vittima e chi il carnefice. Che poi esista in De Sanctis del risentimento è vero, ed è centrale nella sua identità, ma il momento in cui fa veramente il salto di qualità è quando incomincia a indagare la natura del suo personale risentimento e non solo quello degli altri. Continua a raccogliere informazioni su sé stesso e sul suo rapporto con il mondo, insomma, tematizza l’odio, ne capisce il potere, capisce che non riguarda solo i suoi «nemici» – che nella nostra epoca polarizzata sono per definizione «gli odiatori» – bensì tutti, lui compreso. Da un certo punto in poi per lui non si tratta più di rivincita, ma al contrario di fare qualcosa di buono per gli altri, anche se in una maniera che appare controintuitiva e per molti versi anche terribile. Il meccanismo in questo caso è puramente letterario, è una sorta di distorsione della realtà per evidenziare nel processo aspetti concretissimi della nostra natura profonda.
Apriamo una finestra sull’odio, che tutti proviamo ma in pochi sapremmo definire. Nel tuo romanzo vanno in scena odi interpersonali, ma si guadagna il titolo la dimensione collettiva di questo sentimento: l’odio come persecuzione sociale, che nel pensiero di René Girard viene sedato temporaneamente dal meccanismo del caprio espiatorio. Senza l’incontro con questo filosofo è difficile immaginare il tuo romanzo, che io vedo costruito su due nuclei di riflessione filosofica: la relazione tra Uomo e tecnologia, da tempo centrale nella tua indagine, e il pensiero di René Girard. Come hai incontrato Girard? Perché proprio lui?
L’odio è un sentimento interessante non solo perché è la polarità negativa dell’amore, ovvero quanto c’è di più bello e prezioso nella vita, ma anche perché è sempre più facile vederlo negli altri che in se stessi, e questa esternalizzazione è una spia interessante del suo funzionamento profondo. Girard è un pensatore di un’attualità senza molti paragoni forse proprio perché non ha mai creduto all’idea dell’uomo come lavagna bianca su cui fosse possibile scrivere qualsiasi cosa, al contrario ha sempre ammonito che alcuni tratti della specie sono se non eterni, comunque ben lungi dall’essere scomparsi e fra questi c’è anche la forza fondativa dell’odio. Oggi grandi cambiamenti sia tecnologici sia culturali rendono evidente quanto avesse ragione, da qui la sua ritrovata importanza. Per Girard i capisaldi di ogni civiltà umana erano sostanzialmente due: l’imitazione mimetica, ovvero la nostra tendenza a desiderare quello che desiderano gli altri e poi, quando da questa convergenza di desideri nasce una sorta di guerra di tutti contro tutti, risolvere il problema, e pacificare così la società, attraverso il sacrificio di un capro espiatorio. Una vittima innocente che poi un giorno – una volta rimossa dalla memoria il ricordo di quella barbara violenza collettiva – verrà divinizzata. Quella a cui assistiamo oggi è una moltiplicazione quasi esponenziale dei sacrifici di capri espiatori, è perfettamente normale celebrare continuamente dei simbolici roghi rituali online sulla pelle di persone nei confronti delle quali non è iniziato nemmeno un processo e forse non inizierà mai.
Quando siamo online tutto è molto chiaro, lineare, è molto facile odiare, è molto facile condannare, le spiegazioni sono univoche, i “cattivi” del tutto auto-evidenti, in realtà definiamo le nostre bolle social prima di qualsiasi altra cosa attraverso l’individuazione di quali sono le persone e i gruppi che siamo chiamati ad odiare in automatico. È l’odio che definisce i confini della tribù, e dico «odio» proprio perché il più delle volte è un’ostilità meccanica, non ragionata. Prendiamo brandelli d’informazione, spesso arbitrari ed episodici, e li usiamo per giudicare intere vite, con una leggerezza e un automatismo che se osservati da vicino fanno venire i brividi. Condannare delle persone alla gogna, alla perdita del lavoro e della dignità civile non è mai stato così semplice e rapido, né fatto con tanta diffusa noncuranza. Tutto questo mi sembrava un fenomeno degno d’indagine. La spiegazione che Girard dava del fenomeno del capro espiatorio mi era sempre sembrata molto profonda ma quando ho scoperto che il primo investitore di rilievo in Facebook era stato Peter Thiel – allievo e seguace di René Girard – mi è sembrato di essere su una strada promettente.
Torniamo a Marco, una cosa che colpisce di lui è che si tratta di un umanista che non rifiuta il suo tempo, che non si chiude alla società perché non gli permette di fare il lavoro che sognava da adolescente o non valuta a sufficienza il suo percorso di studi. È un ferito che muove oltre invece che consumarsi in un risentimento immobile.